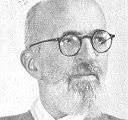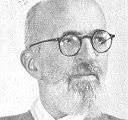Una delle tematiche che, fin dalle origini, ha travagliato il movimento socialista internazionale è quella del rapporto tra socialismo e democrazia. Il che, fra l'altro, presuppone una definizione certa dell'uno e dell'altra: impresa quanto mai difficile. E, infatti, considerando le diversità storiche e ambientali dell'azione socialista nel mondo, molteplici, e a volte contrastanti, appaiono le risposte operative di chi al socialismo diceva di richiamarsi.
In Italia il movimento socialista, anche dopo la scissione comunista, che prese strade (e nomi) diversi, fu sempre diviso tra una destra “riformista” e una sinistra “rivoluzionaria”, anche quando esse assunsero denominazioni diverse, presentandosi nelle varie situazioni come socialismo classista, socialdemocrazia, fusionismo, frontismo, autonomismo, laburismo, liberalsocialismo. Tuttavia la divisione non fu mai netta e definitiva, perché tra le due fazioni ci fu sempre un'area che in altra sede [1] abbiamo definito composta da riformisti di sinistra e da rivoluzionari di destra, peraltro scarsamente omogenea al suo interno, la quale nel corso degli anni ha dato al dibattito interno socialista importanti risposte, che spesso hanno avuto forti ripercussioni anche nella vicenda politica generale italiana. Di questa tormentata, ma interessante area politica, originale interprete fu Ugo Guido Mondolfo.
Ugo Guido, nato a Senigallia (AN) il 26 giugno 1875, era il primogenito di un'agiata famiglia di commercianti ebrei, formata dal padre Vito, dalla madre Sigismonda Padovani, dalle sorelle Evelina e Ida e dal fratello Rodolfo [2]. Terminati gli studi liceali, ad appena 17 anni si iscrisse all'università di Firenze e nel 1896 conseguì la laurea in Lettere.
Durante gli studi universitari, aveva preso a frequentare, assieme al fratello Rodolfo, che lo aveva raggiunto a Firenze, un gruppo di giovani socialisti, fra cui Gaetano Salvemini[ 3], Cesare Battisti [4] e la futura moglie di Battisti Ernesta Bittanti [5]. Nel 1895 aderì al PSI e l'anno dopo divenne redattore del settimanale socialista Il Domani.
Tale collaborazione cessò quando il neodottore, per conseguire una seconda laurea in Giurisprudenza, decise di trasferirsi a Siena, dove collaborò a un altro giornale socialista, La Riscossa, di cui nel 1898 divenne direttore.
Ma nello stesso anno 1898, in seguito alla proclamazione dello stato d'assedio [6], il giornale venne chiuso e il suo direttore mandato sotto processo per aver promosso una manifestazione sediziosa. Mondolfo se la cavò per “insufficienza di prove” e nel 1899 si laureò anche in giurisprudenza. Ma la sua vera vocazione era la ricerca storica e perciò lasciò perdere l'avvocatura e si dedicò ad essa e all'insegnamento. Il primo incarico lo ebbe nel 1901 al ginnasio “Pintor” di Cagliari; ma l'anno dopo tornò a Siena. Nello stesso 1901, in una con lo storico e filologo Giuseppe Kirner e con Gaetano Salvemini, fondò la Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media (FNISM) [7]. Nel 1908 si trasferì all'istituto tecnico di Terni e due anni dopo, come vincitore di concorso, al liceo “Berchet” di Milano [8].
A Milano, centro pulsante del socialismo italiano, nella città di Filippo Turati, di Anna Kuliscioff, di Costantino Lazzari, egli ritrovò il gusto della politica attiva. Nel dibattito che da sempre ravvivava e travagliava la vita interna del PSI, Mondolfo si era subito schierato con la corrente riformista, per la quale aveva votato in tutti i congressi a cui aveva partecipato come delegato della sezione di Senigallia, da lui stesso fondata. Il suo era però un riformismo di sinistra, che affondava le sue radici in un'interpretazione evoluzionista del marxismo e che non perdeva di vista il fine ultimo della lotta: l'instaurazione di una società socialista.
Ma in occasione dell'XI congresso del PSI (Milano, 21-25/10/1910), aderì, come anche Salvemini, ad un gruppo di riformisti “dissidenti” capeggiati da Emanuele Modigliani, detti “intermedi”, che per l'occasione si erano alleati con gli integralisti di Oddino Morgari [9]. Nelle elezioni politiche del 26 ottobre 1913, Mondolfo si candidò nel collegio di Lodi, ma non venne eletto [10]. Ma l'anno dopo, in occasione del XIV congresso del PSI (Ancona, 26-29/4/1914) ottenne una duplice soddisfazione: fu approvato all'unanimità un ordine del giorno, da lui redatto, contro il protezionismo negli scambi internazionali e fu sancita l'incompatibilità, da lui fortemente auspicata, tra l'appartenenza alla massoneria e l'iscrizione al PSI.
Il successivo 14 giugno 2014 Ugo Guido fu tra gli eletti al Consiglio Comunale di Milano del PSI, che in quell'occasione conquistò la maggioranza [11] ed elesse sindaco Emilio Caldara (1868-1942), della cui giunta Mondolfo entrerà a far parte per un breve periodo nel 1919, come assessore all'Urbanistica e al Piano Regolatore.
Allo scoppio del primo conflitto mondiale [12], prese le distanze dal cosiddetto ”interventismo democratico” [13] e si dichiarò neutralista, senza forzature estremistiche, ma tentando di conciliare il pacifismo con l'amor di patria. Su questo terreno si riavvicinò a Filippo Turati e al riformismo ufficiale e intensificò la sua collaborazione alla rivista dal Turati fondata e diretta, Critica Sociale [14].
La sua attività politica si fece via via più intensa: partecipò, infatti al XV congresso socialista (Roma, 1-5/9-1918) e al XVI (Bologna, 5-8/10/1919), sempre schierato con la corrente riformista, ormai denominata Concentrazione socialista, costruita attorno a Critica Sociale.
Partecipò anche all'importante convegno riformista di Reggio Emilia del 10-12 ottobre 1920, in cui la corrente decise la sua posizione in vista dello storico congresso di Livorno, previsto per il successivo gennaio 1921, in cui si doveva discutere in merito all'adesione alla Terza Internazionale e che si concluderà con la scissione comunista. Col documento finale la corrente si schierò per il mantenimento del nome di PSI, per la salvaguardia dell'unità del partito, nella libertà di espressione e nella disciplina; essa accettava la dittatura del proletariato, ma intendendola come una necessità transitoria imposta da speciali situazioni e non come un obbligo programmatico.
La freddezza di Mondolfo verso il bolscevismo e la Rivoluzione russa indussero la maggioranza massimalista milanese a non ripresentarlo alle elezioni amministrative del 1920.
Mentre cominciava quella che Nenni definirà l'orgia delle scissioni, dilagava, in tutta Italia, la violenza fascista e gli squadristi smantellavano, pezzo per pezzo, le organizzazioni proletarie e democratiche, mentre il PSI, benché forte di 156 deputati, si crogiolava nelle polemiche intorno alla Terza Internazionale. Solo in seguito furono finalmente più decisi i riformisti, minoritari nel partito, ma maggioritari nel gruppo parlamentare, nel rompere finalmente gli indugi. Dunque Turati, violando la disciplina di partito, partecipò alle consultazioni del Re, in occasione della crisi di fine luglio 1922, per cercare di ottenere la formazione di un governo non connivente coi fascisti. Purtroppo inutilmente.
Fu l'occasione che i massimalisti aspettavano, per espellere i riformisti dal partito e per poter quindi finalmente esaudire le imposizioni di Mosca e poter così entrare nell'IC. L'espulsione avvenne nel corso del XIX congresso (Roma, 1-4/10/1922) [15].
I riformisti, la mattina del 4 ottobre 1922, si riunirono a parte e costituirono il Partito Socialista Unitario (PSU), con segretario Giacomo Matteotti e vice Emilio Zannerini e organo di stampa La Giustizia, con direttore Claudio Treves [16]. Mondolfo era tra i costituenti del nuovo partito, il quale lo candidò alle amministrative di Milano del successivo 7 novembre 1922. Mondolfo risultò eletto, ma come consigliere di minoranza, essendo state vinte le elezioni da una coalizione di destra.
Intanto il fascismo andava consolidando il suo potere, nonostante lo sbandamento seguito all'assassinio di Matteotti (10-6-1924), superando anche il periodo dell'Aventino [17] e il fallito attentato Zaniboni [18].
Mondolfo, ormai divenuto di fatto il direttore di Critica Sociale, continuò la sua battaglia scrivendo anche sul settimanale Il Quarto Stato, fondato e diretto Da Pietro Nenni e Carlo Rosselli, che uscì dal 27 marzo al 30 ottobre 1926 [19].
Con l'instaurarsi, in seguito alle leggi fascistissime del 1926, dell'aperta dittatura fascista, per Mondolfo, come per tanti altri, fu impossibile proseguire l'attività politica. Tuttavia egli non si piegò mai al regime e si concentrò sull'attività si insegnante. Ma anche in quel campo, per le sue idee politiche, dovette subire delle angherie che si concretizzarono nel trasferimento al liceo Manzoni e poi al Parini, sempre di Milano. Infine, a seguito delle leggi razziali del 1938, in quanto di origine ebrea, fu allontanato dall'insegnamento.
Con l'ingresso in guerra dell'Italia fascista [20], fu arrestato, assieme ad altri ebrei milanesi, e rinchiuso nel carcere di S. Vittore per quasi un mese, per essere poi internato a Macerata Feltria, nel Pesarese. Dopo qualche mese, tuttavia, per ragioni di salute, poté tornare a Milano e, in seguito, alla sua città d'origine, Senigallia.
Il 1943 fu un anno denso di importanti avvenimenti: lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta del governo fascista, la nomina di un governo monarchico presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio, la liberazione dei carcerati e dei confinati antifascisti (fra cui Nenni, Pertini e Jacometti), il ritorno di molti esuli, la formazione del PSIUP [21] e, infine l'annuncio, l'8 settembre 1943, dell'armistizio, con la contemporanea fuga del Re e del governo Badoglio a Brindisi, per sfuggire alla prevedibile rappresaglia tedesca. A quel punto anche Mondolfo e sua moglie Lavinia [22], entrambi ebrei, decisero di mettersi in salvo, riparando in Svizzera.
Rientrato in Italia dopo la Liberazione, Mondolfo nel settembre 1945, con l'apporto di Giuseppe Faravelli e di Antonio Greppi, ridiede vita a Critica Sociale, di cui divenne direttore. Il primo numero pubblicò un editoriale che così esordiva:
Il nome della rivista si estenderà anche alla corrente neoriformista che attorno ad essa si formerà per cercare di dare concretezza alla sua proposta politica. Il direttore Mondolfo sarà, di fatto, anche la guida della corrente. Con le elezioni amministrative del 7 aprile 1946, le prime dopo il fascismo, in cui il PSIUP si classificò il primo partito della città col suo 32,2 % e 29 consiglieri su 80, Mondolfo fu rieletto consigliere comunale di Milano [23]. Sindaco venne eletto il socialista Antonio Greppi [24].
Intanto nel partito socialista riemergevano, immortali, le due vecchie anime, quella rivoluzionaria e quella riformista, apparentemente inconciliabili [25], sia pure con nomi diversi e in diverse situazioni. Si fronteggiavano allora una „sinistra“, che si riconosceva nella figura del prestigioso Pietro Nenni, la quale privilegiava il momento unitario (col PCI) nella lotta politica, per arginare i più che evidenti tentativi di restaurazione conservatrice; dall'altro lato si era formato un robusto schieramento „autonomista“, guidato da Giuseppe Saragat, schierato in difesa dell'iniziativa autonoma del partito, in assonanza con gli altri partiti socialisti dell'Europa, riuniti nel COMISCO [26].
Le due correnti emersero nitidamente sia nel Consiglio Nazionale del 29 luglio-1° agosto 1945 che nel nel primo Congresso socialista del dopoguerra (Firenze, 11-17 aprile 1946), a cui Mondolfo partecipò come leader della corrente di „Critica Sociale“, che nel congresso ottenne l'11,4 % e due componenti della direzione unitaria [27]. In quella occasione le forze risultarono equilibrate e tutti ebbero il buonsenso di tenere unito il partito, chiamato ad affrontare le votazioni per la Costituente (e per il referendum istituzionale) del 2 giugno 1946.
I risultati del PSIUP per la Costituente furono più che soddisfacenti: secondo posto, dopo la DC, col 20,68 % e 115 deputati su 556. Non così andarono le cose nelle amministrative del novembre successivo e ciò costituì l'occasione per la ripresa delle polemiche, destinate via via a crescere di intensità.
La scissione avvenne nel corso del XXV congresso (Roma, 9-13 gennaio 1947), quando i delegati scissionisti, appartenenti alle correnti di „Iniziativa Socialista“ e di „Critica Sociale“, capitanati da Giuseppe Saragat, si riunirono a Palazzo Barberini e fondarono il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) [28].
Ugo Guido Mondolfo, erede della tradizione turatiana, vi aderì, sia pure senza particolari entusiasmi, interpretando la scissione come una dolorosa necessità. Di essa egli diede un ampio resoconto nel n. 2-3 del 1947 di Critica Sociale, in cui, fra l'altro, scrisse:
Mondolfo entrò nella Direzione del nuovo partito[30], cui aderirono 52 deputati su 115 e importanti personalità del socialismo italiano. Il PSLI si dichiarava classista, considerava suo obiettivo la socializzazione dei mezzi di produzione e sua base ideologica il marxismo, propugnava un'assoluta autonomia dal PCI, pur non escludendo la ripresa di una politica unitaria. Ma il successivo afflusso di nuove leve di iscritti ne avrebbe presto spostato a destra l'asse politico, e quindi il partito avrebbe delineato una nuova e diversa strategia, impersonata soprattutto da Giuseppe Saragat. Lo si vide quando, alla fine del 1947, il PSLI decise di entrare nel governo De Gasperi (DC), il quale coltivava un chiaro disegno centrista. Questa scelta provocò subito qualche emorragia, ma soprattutto costituì, per vari anni, causa di divisione tra coloro che volevano un partito libero da condizionamenti nazionali ed internazionali, sia a sinistra (PCI e URSS) che a destra (DC e USA) e quelli invece orientati ad integrarsi nello schieramento occidentale.
Intanto per le prime elezioni politiche del dopoguerra, fissate per il 18 aprile 1948, il PSLI concluse un accordo con l'UdS [31] per la presentazione di entrambe le formazioni in un unico cartello elettorale chiamato Unità Socialista, il quale ottenne un buon successo (7,1 % e 33 deputati, fra cui Mondolfo).
Ulteriore causa di divisione, alla precedente strettamente connessa, emerse qualche tempo dopo, proprio quando era segretario del Partito U.G. Mondolfo, eletto dalla Direzione il 7 marzo 1949. Si trattava dell'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, osteggiata dalle sinistre interne del PSLI e fortemente voluta dalla destra socialdemocratica, ormai divenuta maggioritaria nel partito, al punto da costringere alle dimissioni (11-6-1949) il segretario Ugo Guido Mondolfo, esponente del vecchio riformismo classista.
La polemica tra le due anime del PSLI divenne virulenta in occasione del terzo congresso del partito (Roma, 16-19 giugno 1949), vinto dalla mozione di „Concentrazione Socialista“, che raggruppava tutto il centro-destra interno sotto la guida di Saragat, col 63,88 % contro le mozioni unificate di centro-sinistra (Mondolfo, Faravelli) e di sinistra (M. Matteotti, Zagari) che ottennero il 35,15 %. In ballo c'erano la partecipazione ai governi centristi e l'unificazione dei socialisti collocati fuori del PSI. A proposito della quale, mentre la sinistra socialdemocratica era decisamente favorevole ad un congresso di unificazione, fortemente voluto anche dal Comisco, tra le forze interessate (PSLI, UdS e MAS [32]), la destra propendeva, non a caso, per un ingresso individuale nel PSLI dei militanti degli altri due gruppi.
Infatti essa temeva che ad un'eventuale assemblea costituente per la fondazione del nuovo partito unificato, la somma degli iscritti di UdS, MAS e sinistra socialdemocratica potesse consegnare la maggioranza del nuovo partito unificato alla sinistra interna, con grave pregiudizio per la partecipazione governativa del PSLI, dalla destra socialdemocratica invece fortemente voluta e difesa. Dell'esito del congresso del PSLI rimasero insoddisfatti sia il MSA, contrario al governo a direzione democristiana, che l'UdS, che si dichiarò contraria sia all'egemonia democristiana sul governo, sia all'egemonia comunista sulla sinistra.
Tali prese di posizione allarmarono la nuova direzione di destra del PSLI (ora guidato da Ludovico D'Aragona), timorosa che nel nuovo partito prevalessero le tendenze neutraliste e antigovernative; al punto che, il 31 ottobre 1949, essa annunciò il ritiro del PSLI dal congresso di unificazione, già fissato a Firenze per il 4 dicembre successivo.
La scissione della sinistra PSLI, guidata da Mondolfo divenne perciò inevitabile. Il 3 novembre 1949 il „Comitato centrale della corrente per l'Unità Socialista“ (sinistra PSLI) dichiarò di non riconoscere la decisione della Direzione di destra del PSLI e di voler procedere verso l'unificazione con gli altri gruppi (MSA e UdS) nell'apposito congresso già fissato.
Il "Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista“, formato dalle tre organizzazioni interessate, in cui la sinistra del PSLI era rappresentata da Ugo Guido Mondolfo e da Giuseppe Faravelli [33] dunque portò a termine i suoi lavori, senza la partecipazione del PSLI ufficiale. Al teatro Niccolini di Firenze si aprì il congresso di fondazione (4-8 dicembre 1949) del Partito Socialista Unitario (PSU). Al nuovo partito aderirono 15 deputati e 10 senatori socialisti di diversa provenienza.
Secondo la "Dichiarazione di principi“, approvata dal congresso, il PSU, restava fedele ai principi generali del socialismo enunciati nel programma di Genova del 1892 e il suo scopo fondamentale era la lotta per l'emancipazione della classe lavoratrice dall'oppressione e dallo sfruttamento capitalistico. Era respinto ogni genere di dittatura, in quanto la classe lavoratrice poteva attuare il socialismo soltanto con metodi democratici, e ribadita la fedeltà all'Internazionale Socialista.
Il PSU fu subito riconosciuto dal Comisco, che espulse dalle sue file il PSLI. La Direzione [34] elesse segretario il prestigioso direttore di Critica Sociale. Mondolfo però nel 1950, per ragioni di salute, si dimise e, al suo posto, il 20 settembre 1950, fu eletto Ignazio Silone. Il secondo congresso del Partito (Torino, 27-29 gennaio 1951) registrò la vittoria della mozione dei “fusionisti” (col PSLI) di Giuseppe Romita, che prevalsero di misura sugli “autonomisti” delle altre componenti. Come segretario fu eletto Giuseppe Romita [35], per cui furono accelerate le trattative per la fusione PSU – PSLI, che avvenne il 1° maggio 1951. Il nuovo partito assunse la denominazione di Partito Socialista-Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista (PS-SIIS), e fu ammesso, come unico rappresentante dell'Italia, nella costituenda Internazionale Socialista.
Pochi mesi dopo (Bologna, 3-6 gennaio 1952) si tenne il congresso del PS-SIIS, il quale ratificò la fusione, decise di modificare la denominazione del Partito in Partito Socialista Democratico italiano (PSDI), ma fin dagli inizi si presentò diviso in varie correnti e quindi destinato ad un'accesa dialettica interna. I delegati approvarono anche un ordine del giorno, presentato da Codignola e Mondolfo, che impegnava il partito a difendere rigorosamente la proporzionale pura e a presentarsi alle elezioni politiche, previste per l'anno successivo, senza apparentamenti con altre forze.
A scatenare in proposito una virulenta polemica interna, fu la presentazione alla Camera (21-2-1952), da parte della maggioranza centrista governativa (DC, PSDI, PRI, PLI) di un disegno di legge che prevedeva che il partito – o la coalizione di partiti – che avesse ottenuto anche un solo voto in più del 50 %, avrebbe avuto diritto all'assegnazione dei due terzi dei seggi alla Camera [36]. Il sostegno alla cosiddetta legge-truffa [37], al Congresso di Genova del 4-7 ottobre 1952, finì per essere approvato dall'area di centro-destra prevalente nel PSDI, con l'opposizione della sola sinistra (20,2 %) di Codignola, Faravelli e Mondolfo, ritornato all'attività politica. Mondolfo, comunque, entrò nella nuova Direzione.
Il dibattito nella socialdemocrazia divenne via via piú aspro fra favorevoli e contrari alla proporzionale. Ma Mondolfo rimase sempre fedele ai suoi principi: