ORESTE LIZZADRI
27-01-2025 - GALLERIA SOCIALISTA di Ferdinando Leonzio
 Simbolo Partito Socialista Italiano
Simbolo Partito Socialista Italiano
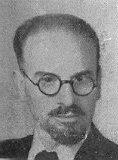 Nicola Perrotti
Nicola Perrotti
 Emilio Canevari
Emilio Canevari
 Lelio Basso
Lelio Basso
 Giuliano Vassalli
Giuliano Vassalli
 Giuseppe Di Vittorio
Giuseppe Di Vittorio
 Simbolo CGIL
Simbolo CGIL
 Achille Grandi
Achille Grandi
 Bruno Buozzi
Bruno Buozzi
 Fernando Santi
Fernando Santi
Ci sono personaggi nella vicenda umana che, pur cadendo sotto i riflettori della storia solo occasionalmente, in punta di piedi e senza clamori, sono invece riusciti a determinarne in maniera significativa gli eventi.
Uno di essi fu certamente Oreste Lizzadri, la cui azione ha lasciato tracce profonde nei campi in cui operò: quello sindacale, anzitutto, quello politico e quello per la lotta antifascista e per la democrazia.
Se fosse possibile definire un uomo con una sola parola, quella per Lizzadri non potrebbe essere altra che coerenza, poiché la sua azione, al di là del mutevole scenario politico, fu sempre ispirata ad un principio di fondo: quello dell'unità del movimento operaio.
Oreste, unico maschio dei quattro figli della coppia Canio Lizzadri, capostazione socialista, e Albina Longobardi, nacque il 17 maggio 1896 a Gragnano (NA), la città della pasta. E sarà proprio da un pastificio di Gragnano che partirà la scintilla da cui avrà origine una vera e propria, irrevocabile, scelta di vita.
In seguito alla morte del padre, avvenuta nel 1911, il giovane Oreste fu costretto a interrompere gli studi [1], per impiegarsi, a soli 15 anni, in uno dei pastifici della sua città. Ebbe così modo di conoscere, in maniera palpabile, la durezza del lavoro, di un lavoro, ancora senza adeguata tutela e lasciato all'arbitrio padronale. Capì dunque, da giovanissimo, il significato della parola “sfruttamento”, assai simile a quello che negli stessi anni subivano i “carusi siciliani”, impiegati nelle miniere di zolfo. I giovani pastai erano alla mercé del proprietario, che stabiliva il ritmo del lavoro e il livello, ovviamente bassissimo, dei salati, per una giornata lavorativa interminabile, che arrivava fino a 16 ore [2].
Presa coscienza, sulla propria pelle, dell'opprimente condizione degli operai, il giovanissimo Oreste nell'aprile 1913 si fece promotore di uno sciopero dei pastai che ebbe esito positivo. L'entusiasmo dei lavoratori portò il neo-sindacalista ad assumere, a soli 17 anni!, la segreteria della locale Camera del Lavoro. Il 13 aprile dello stesso anno fu tra i fondatori della sezione del PSI di Gragnano: Il suo destino politico e sindacale era ormai tracciato.
Nello stesso periodo Lizzadri frequentava la vicina Castellammare di Stabia, dove si trovava una combattiva classe operaia e dove veniva pubblicato il quindicinale La Voce, fondato e diretto da Ignazio Esposito; il giornale era influenzato dal circolo Carlo Marx, fondato a Napoli nel 1912 da Amadeo Bordiga, giovane esponente della corrente “intransigente rivoluzionaria”, vincitrice del congresso di Reggio Emilia del PSI (7-10/7/1912). A tali posizioni di intransigentismo rivoluzionario aderì anche il giovane sindacalista Oreste Lizzadri, nel 1914 già divenuto segretario dell'agguerrita Camera del Lavoro di Castellammare. Ma quell' esperienza non durò per molto. Scoppiata la guerra [3], Oreste fu chiamato alle armi e prestò servizio come telegrafista della marina guadagnandosi una croce di guerra al valor militare.
A guerra finita, dopo una breve permanenza a Napoli [4], nel cui ambiente socialista predominava la forte personalità di Amadeo Bordiga, si trasferì a Roma, avendovi trovato un impiego in un istituto di credito, nel cui ambito si attivò per organizzare sindacalmente i bancari.
Lontano fisicamente da Napoli e da Bordiga, Lizzadri se ne staccò anche politicamente e, in occasione del congresso socialista di Livorno, non segui gli scissionisti che il 21 gennaio 1921 fondarono il Partito Comunista d'Italia (PCdI) [5]. Lizzadri rimase col leader massimalista Giacinto Menotti Serrati, anche quando, nell'ottobre 1922, espulsi i riformisti [6], questi si spostò su posizioni terzinternazionaliste, favorevoli alla fusione tra PSI e PCdI. Tuttavia quando, nel 1924, i terzinternazionalisti, ormai rimasti in minoranza nel PSI, decisero di confluire nel PCdI [7], Lizzadri non li seguì e, ancora una volta, rimase fedele al PSI.
Nel 1926 le leggi fascistissime trasformarono definitivamente il governo fascista in regime fascista, rendendo legalmente impossibile ogni attività politica. Agli antifascisti che non riuscirono a riparare all'estero e a quelli che non finirono in carcere o al confino, non restò altro che la resistenza silenziosa e dignitosa, nell'attesa della rivincita democratica.
Durante il fascismo, perso il lavoro in banca, Lizzadri si impiegò presso un'azienda vinicola, di cui in seguito diventerà direttore e comproprietario. Questo nuovo lavoro gli diede la possibilità di girare per l'Italia, per contattare non solo i clienti della ditta, ma anche vari gruppi clandestini socialisti del Lazio, dell'Abruzzo e dell'Umbria.
A Roma, fin dal 1938, Lizzadri entrò in contatto con un gruppo di vecchi socialisti: Olindo Vernocchi, ultimo segretario del PSI prima dello scioglimento dei partiti, l'ex deputato Giuseppe Romita, lo psicanalista Nicola Perrotti, nella cui abitazione si svolgevano gli incontri clandestini, il sindacalista ed ex deputato Emilio Canevari.
Dopo le prime difficoltà belliche dei nazifascisti [8] in Grecia, Jugoslavia e URSS, e dopo aver consultato vari altri socialisti sparsi nello Stivale, i cinque, riunitisi nello studio di Olindo Vernocchi In data 29 luglio 1942, approvarono l'atto di ricostituzione del PSI e si costituirono componenti di un Esecutivo segreto e permanente, con segretario Giuseppe Romita e vicesegretario Oreste Lizzadri, i quali, con le opportune cautele, ripresero a girare l'Italia, per contattare altri militanti [9]. Intanto si erano costituiti in Italia due altri movimenti di ispirazione socialista, formati essenzialmente da giovani e fra loro assai vicini politicamente:
- il Movimento di unità Proletaria per la Repubblica Socialista (MUP), con leader Lelio Basso [10], che si proponeva il superamento del “tatticismo” riformista e del “nullismo” massimalista;
- l'Unione Proletaria (UP), formata a Roma da giovani antifascisti che aderivano al socialismo inteso come realizzazione delle libertà individuali e collettive [11].
Il 22 e 23 agosto ebbe luogo a Roma, proprio in casa di Lizzadri, in viale Parioli 44, un convegno fra i rappresentanti delle tre formazioni socialiste, presenti una quarantina di persone [12], per decidere la costituzione di un partito socialista unico, che prese il nome di Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) [13], con Nenni segretario del partito e direttore dell'Avanti! e Andreoni e Pertini vicesegretari [14].
Dopo l'annuncio dell'armistizio tra Italia e Alleati dell'8 settembre 1943, la fuga al Sud del Re e del Governo Badoglio [15], la dissoluzione dell'esercito italiano, l'occupazione nazista di Roma (10-9-1943) e dell'Italia centro-settentrionale, la penisola rimase divisa in due:
- il Centro-Nord occupato dai tedeschi e amministrato dal governo fantoccio della neo proclamata Repubblica Sociale Italiana (RSI), capeggiata da Mussolini e dal risorto partito fascista, ora rinominato Partito Fascista Repubblicano (PFR). All'interno di questo territorio, detto anche “Repubblica di Salò”, sorsero le formazioni partigiane e la Resistenza contro il nazi-fascismo;
- il Regno del Sud, con sede prima a Brindisi e poi a Salerno, occupato dagli Alleati, rappresentava la continuità istituzionale del Regno d'Italia. Nel suo territorio i partiti poterono riprendere ad operare.
Nel territorio di Salò il neo costituito PSIUP, come tutti gli altri partiti antifascisti, fu invece costretto a rientrare nella clandestinità.
Venne costituito il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) [16], che assunse la direzione della lotta antifascista. In seguito all'arresto di Pertini e alle dimissioni da vicesegretario di Andreoni, dal PSIUP venne nominato un esecutivo segreto, composto dal segretario del partito Nenni, dal giovane Giuliano Vassalli [17] e da Oreste Lizzadri, da tempo fra i principali dirigenti del partito socialista, come dimostra anche il fatto che il 9 gennaio 1944 fu lui ad essere delegato a rappresentare il PSIUP nella Giunta Militare Centrale del Corpo Volontari della Libertà (CVL), che dirigeva la Resistenza armata contro gli occupanti nazisti e i loro alleati fascisti “repubblichini”.
Diversamente andarono le cose nell'Italia meridionale occupata dagli Alleati, dove cominciarono a riemergere, dopo vent'anni di dittatura, gruppi, circoli e sezioni socialiste, i cui rappresentanti, nello studio dell'avv. Lelio Porzio [18], che ne era l'animatore, costituirono il Partito Socialista dell'Italia liberata.
Esso tenne a Napoli, il 20 dicembre 1943, il suo primo convegno, che si occupò di varie tematiche: situazione politica, sindacato, organizzazione del partito, organizzazione giovanile, stampa e propaganda e, soprattutto, problema istituzionale, a proposito del quale veniva momentaneamente accantonata la pregiudiziale di intransigenza repubblicana, privilegiando invece l'ingresso socialista nel governo [19]. Fu, infine, eletto un Consiglio Nazionale, composto da un rappresentante per ogni Federazione, dal quale scaturì la Direzione del partito con segretario Lelio Porzio [20].
In occasione del Congresso dei partiti antifascisti di Bari, dunque nell'Italia liberata, indetto per il 28-29 gennaio 1944, il Comitato Centrale del CLN incaricò Lizzadri di portarvi un proprio messaggio: missione assai pericolosa, dovendosi attraversare la linea di combattimento fra i due schieramenti. Per farlo egli assunse il nome di Oreste Longobardi (nome proprio e cognome della madre) e partì il 23 gennaio. Per l'occasione Lizzadri fu anche incaricato dal PSIUP centrale di consegnare ai socialisti meridionali una lettera, firmata da Bruno Buozzi e Pietro Nenni, e condivisa da Lizzadri, in cui si considerava prioritario l'avvento della repubblica, rispetto a ogni partecipazione governativa.
Praticamente, pur essendo i socialisti meridionali per la scelta repubblicana, la rinviavano però al futuro post-bellico: si manifestava dunque una certa divergenza con la Direzione romana sulla tattica del momento, circa la partecipazione o meno ad un governo del Re.
Il dissenso emerse alla luce del sole nella riunione – presente Lizzadri - della Direzione meridionale del 21 marzo 1944, che riconfermò il suo orientamento a favore di un compromesso provvisorio con la monarchia, per la formazione di un governo rappresentativo e antifascista. Lizzadri ritenne allora opportuno rinviare ogni decisione al Consiglio Nazionale. Lo stesso Lizzadri, fortemente unitario, visto che anche i comunisti, prima assertori di una rigida pregiudiziale repubblicana, si erano rapidamente allineati alla posizione indicata da Togliatti, si adoperò, con realismo politico, perché anche il PSIUP convergesse su questa nuova e realistica linea. Visto l'esito della riunione del 15-16 aprile 1944 del Consiglio Nazionale del partito socialista dell'Italia liberata, infatti, la Direzione all'unanimità, ed anche lo stesso Lizzadri, si pronunciarono per la partecipazione al governo, rinviando la questione istituzionale a liberazione dell'Italia avvenuta [21]. La Direzione meridionale fu rimaneggiata, con Oreste Lizzadri nuovo segretario del partito, affiancato da due vicesegretari: Lelio Porzio e Luigi Cacciatore e con Nino Gaeta direttore dell'Avanti!
Nello stesso periodo Lizzadri si occupò con grande passione della questione sindacale, sia in merito al commissariamento delle organizzazioni fasciste [22], che per la realizzazione dell'auspicata unità sindacale.
Le trattative per l'unificazione furono portate avanti per diversi mesi dai leader delle maggiori correnti sindacali: Bruno Buozzi e Oreste Lizzadri per quella socialista, Giuseppe Di Vittorio e Giovanni Roveda per la comunista e Achille Grandi e Giovanni Gronchi per la democristiana. L'accordo raggiunto il 3 giugno, noto come “Patto di Roma”, fu firmato da Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i democristiani e, in assenza di Buozzi, arrestato il 13/4 e poi trucidato dai nazisti [23], ed essendo Lizzadri ancora nel Meridione, Emilio Canevari per i socialisti. Il nuovo sindacato unitario, denominato Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), si basava su alcuni principi base: unità, democrazia interna, libertà di espressione, rispetto per le opinioni politiche, ideali e religiose, indipendenza dai partiti politici. La segreteria era costituita da Di Vittorio, Grandi e Canevari, poi sostituito da Lizzadri.
Il 2 giugno 1944 si era tenuta l'ultima riunione del PSI meridionale, in cui era stata nominata, al posto del segretario Lizzadri, che doveva rientrare a Roma, una segreteria collegiale composta da Cacciatore, Gaeta e Porzio.
Tuttavia, quando Roma fu liberata (4-6-1944), la Direzione centrale del PSIUP riacquistò libertà d'azione e rientrò nei suoi concreti poteri statutari, per cui quelli del Partito Socialista meridionale andarono a incanalarsi nella realtà organizzativa nazionale.
Riprendeva, intanto, all'interno del partito, il logorante dibattito, politico e ideologico, sulla collocazione del PSIUP e sui suoi rapporti col PCI [24], un tema fin troppo discusso fra i socialisti, allora in parte unitari o fusionisti e in parte autonomisti.
Le varie posizioni erano sostenute da una grande fioritura di riviste socialiste, tutte di alto profilo politico-culturale: Critica Sociale, diretta da Ugo Guido Mondolfo, che si rifaceva al riformismo turatiano, Politica di classe di Rodolfo Morandi, Quarto Stato di Lelio Basso, Iniziativa Socialista di Mario Zagari, Europa Socialista di Ignazio Silone, Compiti Nuovi, settimanale di Oreste Lizzadri, apparso nel luglio 1946.
Uno di essi fu certamente Oreste Lizzadri, la cui azione ha lasciato tracce profonde nei campi in cui operò: quello sindacale, anzitutto, quello politico e quello per la lotta antifascista e per la democrazia.
Se fosse possibile definire un uomo con una sola parola, quella per Lizzadri non potrebbe essere altra che coerenza, poiché la sua azione, al di là del mutevole scenario politico, fu sempre ispirata ad un principio di fondo: quello dell'unità del movimento operaio.
Oreste, unico maschio dei quattro figli della coppia Canio Lizzadri, capostazione socialista, e Albina Longobardi, nacque il 17 maggio 1896 a Gragnano (NA), la città della pasta. E sarà proprio da un pastificio di Gragnano che partirà la scintilla da cui avrà origine una vera e propria, irrevocabile, scelta di vita.
In seguito alla morte del padre, avvenuta nel 1911, il giovane Oreste fu costretto a interrompere gli studi [1], per impiegarsi, a soli 15 anni, in uno dei pastifici della sua città. Ebbe così modo di conoscere, in maniera palpabile, la durezza del lavoro, di un lavoro, ancora senza adeguata tutela e lasciato all'arbitrio padronale. Capì dunque, da giovanissimo, il significato della parola “sfruttamento”, assai simile a quello che negli stessi anni subivano i “carusi siciliani”, impiegati nelle miniere di zolfo. I giovani pastai erano alla mercé del proprietario, che stabiliva il ritmo del lavoro e il livello, ovviamente bassissimo, dei salati, per una giornata lavorativa interminabile, che arrivava fino a 16 ore [2].
Presa coscienza, sulla propria pelle, dell'opprimente condizione degli operai, il giovanissimo Oreste nell'aprile 1913 si fece promotore di uno sciopero dei pastai che ebbe esito positivo. L'entusiasmo dei lavoratori portò il neo-sindacalista ad assumere, a soli 17 anni!, la segreteria della locale Camera del Lavoro. Il 13 aprile dello stesso anno fu tra i fondatori della sezione del PSI di Gragnano: Il suo destino politico e sindacale era ormai tracciato.
Nello stesso periodo Lizzadri frequentava la vicina Castellammare di Stabia, dove si trovava una combattiva classe operaia e dove veniva pubblicato il quindicinale La Voce, fondato e diretto da Ignazio Esposito; il giornale era influenzato dal circolo Carlo Marx, fondato a Napoli nel 1912 da Amadeo Bordiga, giovane esponente della corrente “intransigente rivoluzionaria”, vincitrice del congresso di Reggio Emilia del PSI (7-10/7/1912). A tali posizioni di intransigentismo rivoluzionario aderì anche il giovane sindacalista Oreste Lizzadri, nel 1914 già divenuto segretario dell'agguerrita Camera del Lavoro di Castellammare. Ma quell' esperienza non durò per molto. Scoppiata la guerra [3], Oreste fu chiamato alle armi e prestò servizio come telegrafista della marina guadagnandosi una croce di guerra al valor militare.
A guerra finita, dopo una breve permanenza a Napoli [4], nel cui ambiente socialista predominava la forte personalità di Amadeo Bordiga, si trasferì a Roma, avendovi trovato un impiego in un istituto di credito, nel cui ambito si attivò per organizzare sindacalmente i bancari.
Lontano fisicamente da Napoli e da Bordiga, Lizzadri se ne staccò anche politicamente e, in occasione del congresso socialista di Livorno, non segui gli scissionisti che il 21 gennaio 1921 fondarono il Partito Comunista d'Italia (PCdI) [5]. Lizzadri rimase col leader massimalista Giacinto Menotti Serrati, anche quando, nell'ottobre 1922, espulsi i riformisti [6], questi si spostò su posizioni terzinternazionaliste, favorevoli alla fusione tra PSI e PCdI. Tuttavia quando, nel 1924, i terzinternazionalisti, ormai rimasti in minoranza nel PSI, decisero di confluire nel PCdI [7], Lizzadri non li seguì e, ancora una volta, rimase fedele al PSI.
Nel 1926 le leggi fascistissime trasformarono definitivamente il governo fascista in regime fascista, rendendo legalmente impossibile ogni attività politica. Agli antifascisti che non riuscirono a riparare all'estero e a quelli che non finirono in carcere o al confino, non restò altro che la resistenza silenziosa e dignitosa, nell'attesa della rivincita democratica.
Durante il fascismo, perso il lavoro in banca, Lizzadri si impiegò presso un'azienda vinicola, di cui in seguito diventerà direttore e comproprietario. Questo nuovo lavoro gli diede la possibilità di girare per l'Italia, per contattare non solo i clienti della ditta, ma anche vari gruppi clandestini socialisti del Lazio, dell'Abruzzo e dell'Umbria.
A Roma, fin dal 1938, Lizzadri entrò in contatto con un gruppo di vecchi socialisti: Olindo Vernocchi, ultimo segretario del PSI prima dello scioglimento dei partiti, l'ex deputato Giuseppe Romita, lo psicanalista Nicola Perrotti, nella cui abitazione si svolgevano gli incontri clandestini, il sindacalista ed ex deputato Emilio Canevari.
Dopo le prime difficoltà belliche dei nazifascisti [8] in Grecia, Jugoslavia e URSS, e dopo aver consultato vari altri socialisti sparsi nello Stivale, i cinque, riunitisi nello studio di Olindo Vernocchi In data 29 luglio 1942, approvarono l'atto di ricostituzione del PSI e si costituirono componenti di un Esecutivo segreto e permanente, con segretario Giuseppe Romita e vicesegretario Oreste Lizzadri, i quali, con le opportune cautele, ripresero a girare l'Italia, per contattare altri militanti [9]. Intanto si erano costituiti in Italia due altri movimenti di ispirazione socialista, formati essenzialmente da giovani e fra loro assai vicini politicamente:
- il Movimento di unità Proletaria per la Repubblica Socialista (MUP), con leader Lelio Basso [10], che si proponeva il superamento del “tatticismo” riformista e del “nullismo” massimalista;
- l'Unione Proletaria (UP), formata a Roma da giovani antifascisti che aderivano al socialismo inteso come realizzazione delle libertà individuali e collettive [11].
Il 22 e 23 agosto ebbe luogo a Roma, proprio in casa di Lizzadri, in viale Parioli 44, un convegno fra i rappresentanti delle tre formazioni socialiste, presenti una quarantina di persone [12], per decidere la costituzione di un partito socialista unico, che prese il nome di Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) [13], con Nenni segretario del partito e direttore dell'Avanti! e Andreoni e Pertini vicesegretari [14].
Dopo l'annuncio dell'armistizio tra Italia e Alleati dell'8 settembre 1943, la fuga al Sud del Re e del Governo Badoglio [15], la dissoluzione dell'esercito italiano, l'occupazione nazista di Roma (10-9-1943) e dell'Italia centro-settentrionale, la penisola rimase divisa in due:
- il Centro-Nord occupato dai tedeschi e amministrato dal governo fantoccio della neo proclamata Repubblica Sociale Italiana (RSI), capeggiata da Mussolini e dal risorto partito fascista, ora rinominato Partito Fascista Repubblicano (PFR). All'interno di questo territorio, detto anche “Repubblica di Salò”, sorsero le formazioni partigiane e la Resistenza contro il nazi-fascismo;
- il Regno del Sud, con sede prima a Brindisi e poi a Salerno, occupato dagli Alleati, rappresentava la continuità istituzionale del Regno d'Italia. Nel suo territorio i partiti poterono riprendere ad operare.
Nel territorio di Salò il neo costituito PSIUP, come tutti gli altri partiti antifascisti, fu invece costretto a rientrare nella clandestinità.
Venne costituito il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) [16], che assunse la direzione della lotta antifascista. In seguito all'arresto di Pertini e alle dimissioni da vicesegretario di Andreoni, dal PSIUP venne nominato un esecutivo segreto, composto dal segretario del partito Nenni, dal giovane Giuliano Vassalli [17] e da Oreste Lizzadri, da tempo fra i principali dirigenti del partito socialista, come dimostra anche il fatto che il 9 gennaio 1944 fu lui ad essere delegato a rappresentare il PSIUP nella Giunta Militare Centrale del Corpo Volontari della Libertà (CVL), che dirigeva la Resistenza armata contro gli occupanti nazisti e i loro alleati fascisti “repubblichini”.
Diversamente andarono le cose nell'Italia meridionale occupata dagli Alleati, dove cominciarono a riemergere, dopo vent'anni di dittatura, gruppi, circoli e sezioni socialiste, i cui rappresentanti, nello studio dell'avv. Lelio Porzio [18], che ne era l'animatore, costituirono il Partito Socialista dell'Italia liberata.
Esso tenne a Napoli, il 20 dicembre 1943, il suo primo convegno, che si occupò di varie tematiche: situazione politica, sindacato, organizzazione del partito, organizzazione giovanile, stampa e propaganda e, soprattutto, problema istituzionale, a proposito del quale veniva momentaneamente accantonata la pregiudiziale di intransigenza repubblicana, privilegiando invece l'ingresso socialista nel governo [19]. Fu, infine, eletto un Consiglio Nazionale, composto da un rappresentante per ogni Federazione, dal quale scaturì la Direzione del partito con segretario Lelio Porzio [20].
In occasione del Congresso dei partiti antifascisti di Bari, dunque nell'Italia liberata, indetto per il 28-29 gennaio 1944, il Comitato Centrale del CLN incaricò Lizzadri di portarvi un proprio messaggio: missione assai pericolosa, dovendosi attraversare la linea di combattimento fra i due schieramenti. Per farlo egli assunse il nome di Oreste Longobardi (nome proprio e cognome della madre) e partì il 23 gennaio. Per l'occasione Lizzadri fu anche incaricato dal PSIUP centrale di consegnare ai socialisti meridionali una lettera, firmata da Bruno Buozzi e Pietro Nenni, e condivisa da Lizzadri, in cui si considerava prioritario l'avvento della repubblica, rispetto a ogni partecipazione governativa.
Praticamente, pur essendo i socialisti meridionali per la scelta repubblicana, la rinviavano però al futuro post-bellico: si manifestava dunque una certa divergenza con la Direzione romana sulla tattica del momento, circa la partecipazione o meno ad un governo del Re.
Il dissenso emerse alla luce del sole nella riunione – presente Lizzadri - della Direzione meridionale del 21 marzo 1944, che riconfermò il suo orientamento a favore di un compromesso provvisorio con la monarchia, per la formazione di un governo rappresentativo e antifascista. Lizzadri ritenne allora opportuno rinviare ogni decisione al Consiglio Nazionale. Lo stesso Lizzadri, fortemente unitario, visto che anche i comunisti, prima assertori di una rigida pregiudiziale repubblicana, si erano rapidamente allineati alla posizione indicata da Togliatti, si adoperò, con realismo politico, perché anche il PSIUP convergesse su questa nuova e realistica linea. Visto l'esito della riunione del 15-16 aprile 1944 del Consiglio Nazionale del partito socialista dell'Italia liberata, infatti, la Direzione all'unanimità, ed anche lo stesso Lizzadri, si pronunciarono per la partecipazione al governo, rinviando la questione istituzionale a liberazione dell'Italia avvenuta [21]. La Direzione meridionale fu rimaneggiata, con Oreste Lizzadri nuovo segretario del partito, affiancato da due vicesegretari: Lelio Porzio e Luigi Cacciatore e con Nino Gaeta direttore dell'Avanti!
Nello stesso periodo Lizzadri si occupò con grande passione della questione sindacale, sia in merito al commissariamento delle organizzazioni fasciste [22], che per la realizzazione dell'auspicata unità sindacale.
Le trattative per l'unificazione furono portate avanti per diversi mesi dai leader delle maggiori correnti sindacali: Bruno Buozzi e Oreste Lizzadri per quella socialista, Giuseppe Di Vittorio e Giovanni Roveda per la comunista e Achille Grandi e Giovanni Gronchi per la democristiana. L'accordo raggiunto il 3 giugno, noto come “Patto di Roma”, fu firmato da Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i democristiani e, in assenza di Buozzi, arrestato il 13/4 e poi trucidato dai nazisti [23], ed essendo Lizzadri ancora nel Meridione, Emilio Canevari per i socialisti. Il nuovo sindacato unitario, denominato Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), si basava su alcuni principi base: unità, democrazia interna, libertà di espressione, rispetto per le opinioni politiche, ideali e religiose, indipendenza dai partiti politici. La segreteria era costituita da Di Vittorio, Grandi e Canevari, poi sostituito da Lizzadri.
Il 2 giugno 1944 si era tenuta l'ultima riunione del PSI meridionale, in cui era stata nominata, al posto del segretario Lizzadri, che doveva rientrare a Roma, una segreteria collegiale composta da Cacciatore, Gaeta e Porzio.
Tuttavia, quando Roma fu liberata (4-6-1944), la Direzione centrale del PSIUP riacquistò libertà d'azione e rientrò nei suoi concreti poteri statutari, per cui quelli del Partito Socialista meridionale andarono a incanalarsi nella realtà organizzativa nazionale.
Riprendeva, intanto, all'interno del partito, il logorante dibattito, politico e ideologico, sulla collocazione del PSIUP e sui suoi rapporti col PCI [24], un tema fin troppo discusso fra i socialisti, allora in parte unitari o fusionisti e in parte autonomisti.
Le varie posizioni erano sostenute da una grande fioritura di riviste socialiste, tutte di alto profilo politico-culturale: Critica Sociale, diretta da Ugo Guido Mondolfo, che si rifaceva al riformismo turatiano, Politica di classe di Rodolfo Morandi, Quarto Stato di Lelio Basso, Iniziativa Socialista di Mario Zagari, Europa Socialista di Ignazio Silone, Compiti Nuovi, settimanale di Oreste Lizzadri, apparso nel luglio 1946.
Lizzadri, che si collocava all'estrema sinistra socialista, fu sempre coerente con la sua linea fusionista. Lo si vide in particolare nel Consiglio Nazionale del PSIUP, che si tenne dopo la Liberazione, dal 29 luglio al 1° agosto 1945, prima uscita pubblica del partito.
In essa si confrontarono due linee alternative: quella “unitaria” o di “sinistra” che sosteneva l'esigenza dell'unità della classe operaia e quindi guardava all'unificazione col PCI, vista però dai più come prospettiva non attuale, ma da alcuni a scadenza ravvicinata (fra essi Lizzadri) e una posizione “autonomista” che sottolineava l'opportunità di un'iniziativa autonoma socialista, sostenuta dal gruppo di “Critica Sociale” e da quello di ”Iniziativa Socialista”. Lizzadri entrò nella nuova Direzione scaturita dal convegno, unitaria e rappresentativa di tutte le correnti [25]:
Lizzadri fece parte della Consulta Nazionale [26] e partecipò al XXIV congresso socialista, il primo dopo la Liberazione (Firenze, 11-16/4/1946), caratterizzato da un eccezionale confronto dialettico tra Nenni (unità proletaria) e Saragat (autonomia socialista), conclusosi con un indispensabile compromesso (Pietro Nenni presidente e Ivan Matteo Lombardo segretario), visto l'approssimarsi delle votazioni per l'elezione dell'Assemblea Costituente e per il referendum istituzionale.
Lizzadri, sempre schierato con l'ala sinistra, entrò nella Direzione, in rappresentanza dei sindacalisti socialisti [27].
Impegnato prima nella Consulta, poi nell'Assemblea Costituente e, infine, nella difesa della sua linea fusionista Lizzadri, specialmente dopo la scissione socialdemocratica di Saragat (11-1-1947) [28] , si impegnò a tempo pieno nel partito e nel 1947 lasciò la leadership della corrente socialista della CGIL a Fernando Santi.
Rimase sempre un convinto assertore di una stretta collaborazione col PCI, anche dopo la sconfitta del Fronte Popolare del 18 aprile 1948, in cui comunque fu eletto deputato, e dopo la sconfitta interna della sinistra socialista, costretta a cedere la guida del partito alla corrente “centrista” di Alberto Jacometti e Riccardo Lombardi.
Tornata la sinistra in maggioranza col congresso di Firenze dell'11-16 maggio 1949, Lizzadri rientrò in Direzione, ricoprendo il ruolo di responsabile dell'Ufficio sindacale e lavoro di massa.
Nel febbraio 1952 riprese il suo posto nella segreteria della CGIL [29], dopo la scomparsa di Luigi Cacciatore, di cui prese il posto, rimanendovi fino al 1953. Fu anche riconfermato deputato nelle elezioni del 1953 e in quelle del 1958. Nel 1963 non fu eletto; tuttavia subentrò in seguito al collega Riccardo Fabbri [30], morto nell'ottobre 1967, prima della fine della legislatura.
Lizzadri contrastò la svolta autonomista del PSI, iniziata dopo i fatti d'Ungheria del 1956 e confermata dal congresso di Venezia del 1957, famoso per aver sancito i cardini ideologici e politici del socialismo: democrazia, classismo, internazionalismo. Tuttavia, quando la sinistra del partito, in occasione della formazione del primo governo di centro-sinistra Moro-Nenni [31], decise di uscire dal PSI e di fondare un nuovo partito, denominato PSIUP [32], il suo spirito unitario prevalse e perciò rimase nel PSI.
Ma il 19 giugno 1964, insoddisfatto dei risultati della collaborazione governativa tra socialisti e democristiani, inviò una lettera di dimissioni dal PSI al segretario De Martino, così motivandole in una dichiarazione alla stampa:
La verifica della volontà della DC di realizzare il programma posto alla base del centro-sinistra chiesta dal PSI, si è avuta nei giorni scorsi, ma alla rovescia e rappresenta una decisiva svolta a destra. Di tale svolta si trova conferma oltre che nel discorso di Moro e nella lettera di Colombo, anche in significative manifestazioni del PSI: il voto della Direzione e le affermazioni dell'on. Nenni a Faenza: “Ci sono interessi immediati legittimi che per un anno difficilmente potranno essere soddisfatti: il governo non può cadere sulla casistica del prima o del dopo”.
Occorre ricordare che il C.C. del PSI votó la partecipazione al governo su precisi impegni programmatici: Regioni, legge urbanistica, scuola, leggi agrarie, Federconsorzi, sicurezza sui posti di lavoro. A sette mesi da allora, quanti di tali impegni sono andati in porto? Nessuno. Non solo, ma si parla di risparmio obbligatorio e di proroga dell'aumento delle pensioni ai vecchi lavoratori. Un provvedimento simile, nell'un caso o nell'altro, sarebbe una vergogna. Per le pensioni si tratta di miliardi accumulati su salari differiti e trattenuti sui quali nessun governo è autorizzato a mettere le mani se non con un atto di sfida alla democrazia e ai lavoratori.
Molti socialisti, pur contrari alla politica della maggioranza, non aderirono, come me, al PSIUP sperando che almeno gli impegni programmatici sarebbero stati mantenuti. E, invece, ogni giorno appare sempre piú evidente che l'obiettivo dominante del gruppo collaborazionista del PSI è quello di restare al governo ad ogni costo. Gli attacchi all'Avanti! e ai sindacalisti della CGIL e dell'Alleanza contadina che cercano di contenere la spinta del PSI fino in fondo, ne sono la riprova.
In queste condizioni tradirei la mia coscienza di vecchio socialista se non denunciassi questo stato di cose e non dissociassi la mia solidarietà dalla politica rinunciataria del gruppo dirigente del PSI. Sei mesi fa speravo ancora che la battaglia per il socialismo potesse condursi all'interno del PSI. Gli ultimi avvenimenti hanno distrutta questa speranza. La battaglia per il Socialismo si combatte fuori del PSI [33].
La conseguenza logica di questo severo giudizio non poteva essere altra che l'adesione al PSIUP, cosa che infatti avvenne nel luglio successivo.
Lizzadri ribadì le sue posizioni nel suo intervento al 1° congresso del PSIUP (Roma, 16-19/12/1965), in cui così esordì:
Alcuni compagni rimasti nel PSI e altri che ne uscirono ma ancora non sono con noi ci chiedono tuttora le ragioni profonde del nostro passaggio al PSIUP. Ci chiedono “chi siamo” e “che cosa vogliamo”. Il PSIUP segue i principi del marxismo deducendo le sue linee di azione dall'analisi marxista degli attuali rapporti di classe e trae le sue origini dalla tradizione di lotta del movimento socialista italiano cui intende rimanere fedele. Una fedeltà che si arricchisce delle esperienze negative e positive del movimento operaio internazionale, adeguando la sua azione alle condizioni di oggi. Siamo nel PSIUP per combattere la battaglia socialista del proletariato e siamo contro il centro-sinistra – e la mistificazione in atto nel 36° congresso del PSI [34] - perché esso rappresenta la solita trappola alla buona fede del popolo [35]. […]
Ma il 19 giugno 1964, insoddisfatto dei risultati della collaborazione governativa tra socialisti e democristiani, inviò una lettera di dimissioni dal PSI al segretario De Martino, così motivandole in una dichiarazione alla stampa:
La verifica della volontà della DC di realizzare il programma posto alla base del centro-sinistra chiesta dal PSI, si è avuta nei giorni scorsi, ma alla rovescia e rappresenta una decisiva svolta a destra. Di tale svolta si trova conferma oltre che nel discorso di Moro e nella lettera di Colombo, anche in significative manifestazioni del PSI: il voto della Direzione e le affermazioni dell'on. Nenni a Faenza: “Ci sono interessi immediati legittimi che per un anno difficilmente potranno essere soddisfatti: il governo non può cadere sulla casistica del prima o del dopo”.
Occorre ricordare che il C.C. del PSI votó la partecipazione al governo su precisi impegni programmatici: Regioni, legge urbanistica, scuola, leggi agrarie, Federconsorzi, sicurezza sui posti di lavoro. A sette mesi da allora, quanti di tali impegni sono andati in porto? Nessuno. Non solo, ma si parla di risparmio obbligatorio e di proroga dell'aumento delle pensioni ai vecchi lavoratori. Un provvedimento simile, nell'un caso o nell'altro, sarebbe una vergogna. Per le pensioni si tratta di miliardi accumulati su salari differiti e trattenuti sui quali nessun governo è autorizzato a mettere le mani se non con un atto di sfida alla democrazia e ai lavoratori.
Molti socialisti, pur contrari alla politica della maggioranza, non aderirono, come me, al PSIUP sperando che almeno gli impegni programmatici sarebbero stati mantenuti. E, invece, ogni giorno appare sempre piú evidente che l'obiettivo dominante del gruppo collaborazionista del PSI è quello di restare al governo ad ogni costo. Gli attacchi all'Avanti! e ai sindacalisti della CGIL e dell'Alleanza contadina che cercano di contenere la spinta del PSI fino in fondo, ne sono la riprova.
In queste condizioni tradirei la mia coscienza di vecchio socialista se non denunciassi questo stato di cose e non dissociassi la mia solidarietà dalla politica rinunciataria del gruppo dirigente del PSI. Sei mesi fa speravo ancora che la battaglia per il socialismo potesse condursi all'interno del PSI. Gli ultimi avvenimenti hanno distrutta questa speranza. La battaglia per il Socialismo si combatte fuori del PSI [33].
La conseguenza logica di questo severo giudizio non poteva essere altra che l'adesione al PSIUP, cosa che infatti avvenne nel luglio successivo.
Lizzadri ribadì le sue posizioni nel suo intervento al 1° congresso del PSIUP (Roma, 16-19/12/1965), in cui così esordì:
Alcuni compagni rimasti nel PSI e altri che ne uscirono ma ancora non sono con noi ci chiedono tuttora le ragioni profonde del nostro passaggio al PSIUP. Ci chiedono “chi siamo” e “che cosa vogliamo”. Il PSIUP segue i principi del marxismo deducendo le sue linee di azione dall'analisi marxista degli attuali rapporti di classe e trae le sue origini dalla tradizione di lotta del movimento socialista italiano cui intende rimanere fedele. Una fedeltà che si arricchisce delle esperienze negative e positive del movimento operaio internazionale, adeguando la sua azione alle condizioni di oggi. Siamo nel PSIUP per combattere la battaglia socialista del proletariato e siamo contro il centro-sinistra – e la mistificazione in atto nel 36° congresso del PSI [34] - perché esso rappresenta la solita trappola alla buona fede del popolo [35]. […]
La sua passione socialista divenne davvero incontenibile nell'appello finale del suo discorso, rivolto principalmente ai giovani:
Compagni, avrei finito se non credessi che sia dovere del vecchio socialista dedicare poche parole ai giovani che sono nel nostro partito. I giovani ci accolgono con un certo senso di contrarietà quando si fa appello alla tradizione del socialismo italiano. Quest'appello, sia chiaro, non significa rimanere fermi nella storia, non riconoscere gli errori commessi.
Ma il socialismo italiano non é solo una somma di errori e non alla tradizione dei suoi insuccessi ci appelliamo, ma alla tradizione delle sue vittorie: all'internazionalismo, alla lotta di classe, all'unità dei lavoratori, che nessuna forza e nessuna mistificazione potrà mai dissolvere [36].
Lizzadri venne eletto nel Comitato Centrale e nella Direzione [37] del PSIUP.
Compagni, avrei finito se non credessi che sia dovere del vecchio socialista dedicare poche parole ai giovani che sono nel nostro partito. I giovani ci accolgono con un certo senso di contrarietà quando si fa appello alla tradizione del socialismo italiano. Quest'appello, sia chiaro, non significa rimanere fermi nella storia, non riconoscere gli errori commessi.
Ma il socialismo italiano non é solo una somma di errori e non alla tradizione dei suoi insuccessi ci appelliamo, ma alla tradizione delle sue vittorie: all'internazionalismo, alla lotta di classe, all'unità dei lavoratori, che nessuna forza e nessuna mistificazione potrà mai dissolvere [36].
Lizzadri venne eletto nel Comitato Centrale e nella Direzione [37] del PSIUP.
Il processo di fusione tra PSI e PSDI, favorito dalla comune presenza dei due partiti nel governo e dall'elezione di Saragat al Quirinale, giunse a compimento il 30 ottobre 1966 con la Costituente Socialista, da cui scaturì il PSI-PSDI Unificati, detto anche PSU.
L'unificazione si rivelò però di difficile amalgama, data la diversa cultura politica assunta dai due partiti in vent'anni di separazione; e infatti, dopo solo tre anni, si giunse a una nuova scissione [38]. I socialisti ripresero il nome di PSI e i socialdemocratici il 5 luglio 1969 rifondarono un loro partito che assunse la denominazione di Partito Socialista Unitario (PSU). Ci furono comunque elementi del PSI che passarono al PSU (Mauro Ferri, Pietro Longo) ed elementi provenienti dal PSDI che rimasero nel PSI (Italo Viglianesi, Giorgio Benvenuto). Questi cambiamenti riaccesero in Lizzadri la vecchia fiamma, cioè l'amore per il partito in cui era nato e si era formato e per il quale tanto aveva combattuto: nella Resistenza, nel sindacato, nella Consulta, nell'Assemblea Costituente, in parlamento. Tanto più che ormai il PSI si era liberato dell'abbraccio, da lui non condiviso, con l'ala socialdemocratica. E nel 1969 rientrò nel PSI [39]. Alle elezioni del 1968 non si era più ripresentato e il suo impegno politico con l'età si era affievolito.
L'unificazione si rivelò però di difficile amalgama, data la diversa cultura politica assunta dai due partiti in vent'anni di separazione; e infatti, dopo solo tre anni, si giunse a una nuova scissione [38]. I socialisti ripresero il nome di PSI e i socialdemocratici il 5 luglio 1969 rifondarono un loro partito che assunse la denominazione di Partito Socialista Unitario (PSU). Ci furono comunque elementi del PSI che passarono al PSU (Mauro Ferri, Pietro Longo) ed elementi provenienti dal PSDI che rimasero nel PSI (Italo Viglianesi, Giorgio Benvenuto). Questi cambiamenti riaccesero in Lizzadri la vecchia fiamma, cioè l'amore per il partito in cui era nato e si era formato e per il quale tanto aveva combattuto: nella Resistenza, nel sindacato, nella Consulta, nell'Assemblea Costituente, in parlamento. Tanto più che ormai il PSI si era liberato dell'abbraccio, da lui non condiviso, con l'ala socialdemocratica. E nel 1969 rientrò nel PSI [39]. Alle elezioni del 1968 non si era più ripresentato e il suo impegno politico con l'età si era affievolito.
Morì improvvisamente a Roma, a ottant'anni, il 29 luglio 1976, e per un momento i riflettori tornarono su di lui, per consegnarlo alla storia del movimento operaio italiano. L'Avanti del 31 luglio 1976 gli dedicò ampi servizi, da cui traiamo, tra le tante, alcune importanti testimonianze (telegrammi alla famiglia):
Partito Socialista Italiano
I socialisti italiani apprendono con profondo cordoglio scomparsa compagno Oreste Lizzadri. Ne ricordano con commozione ed orgoglio la figura di militante e di dirigente sindacale e politico ed il ruolo svolto nei momenti drammatici della vita della nazione e l'opera di ricostruzione dell'unità del movimento sindacale e per la rinascita del partito negli anni difficili del dopoguerra. I socialisti italiani conserveranno con devozione la sua memoria e vi sono vicini in questo momento.
Vi porgo a nome della segreteria e della direzione del PSI commosse e fraterne condoglianze.
Vostro Bettino Craxi.
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La CGIL partecipa al generale cordoglio per l'improvvisa scomparsa del compagno Oreste Lizzadri, militante sindacale e socialista.
Valoroso militante della Resistenza e della lotta antifascista, entrato a 15 anni nel movimento politico e sindacale, segretario a 18 anni della Camera del Lavoro di Castellammare di Stabia, attivo partecipante alla lotta clandestina e alla ricostruzione del PSI, rappresentante al Congresso Antifascista di Bari del gennaio '44 del Comitato di Liberazione Nazionale, fra gli artefici del Patto di Roma e Segretario Generale della CGIL unitaria assieme a Giuseppe Di Vittorio ed Achille Grandi, alla testa della CGIL per molti anni fino al 1957, Oreste Lizzadri ha dato con la sua vita e il suo esempio un apporto indimenticabile a tutte le battaglie per l'avanzata e l'emancipazione dei lavoratori. Strenuo e coerente sostenitore dell'unità sindacale dei lavoratori italiani seppe portare nel sindacato un patrimonio di idee e di valori, una forza d'animo e una serenità che ne fecero in ogni momento un protagonista ed un interprete dei diritti di libertà, di giustizia e di pace espressi dal movimento sindacale.
La CGIL nel ricordo di questo suo grande militante, della sua opera e delle comuni battaglie, inchina riverente le sue bandiere e ne raccoglie l'esperienza e l'insegnamento per proseguire fra i lavoratori e in tutto il movimento sindacale il suo impegno di unità e di progresso.
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
I partigiani dell'ANPI ricordano Oreste Lizzadri quale figura esemplare della Resistenza alla quale dedicò il proprio entusiasmo con alto senso di responsabilità. […].
Ai familiari e agli amici e ai compagni di Oreste Lizzadri i partigiani dell'ANPI esprimono il proprio cordoglio ed il rimpianto di aver perso un autentico rappresentante della Resistenza che onorava la presidenza morale nazionale dell'associazione.
- In seguito conseguirà la laurea in Scienze economiche.
- La sua vita di quel periodo é raccontata da Lizzadri nel suo libro La boje! (in italiano, piú o meno= la misura é colma!) del 1974.
- L'Italia entrò in guerra il 24-5-1915, schierandosi con l'Intesa (Regno Unito – Francia – Russia) e dichiarando guerra all'Impero austro-ungarico.
- In quegli anni Bordiga organizzava la sua corrente di estrema sinistra del PSI, attorno al settimanale Il Soviet (1918-1922), da lui diretto.
- Vi aderirono sostanzialmente tre gruppi: quello del Soviet di Bordiga, quello formatosi attorno al giornale L'Ordine Nuovo (Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Angelo Tasca) e quello dei massimalisti di sinistra come Nicola Bombacci ed Egidio Gennari, ex segretari del PSI.
- I riformisti il 4-10-1922 costituirono il Partito Socialista Unitario (PSU), con segretario Giacomo Matteotti. Vi aderivano Filippo Turati, Claudio Treves, Emanuele Modigliani, Rinaldo Rigola, Oddino Morgari, Bruno Buozzi, ecc.
- Non il gruppo terzinzernazionalista formatosi attorno al prestigioso ex segretario del partito, Costantino Lazzari, che rimase nel PSI fino alla morte.
- L'Italia fascista era entrata in guerra a fianco delle Germania nazista il 10.6.1940.
- A Milano aderirono personaggi di grosso prestigio come Antonio Greppi, Ivan Matteo Lombardo, Alcide Malagugini, Lina Merlin e il vecchio Gregorio Agnini, uno dei fondatori del partito a Genova nel 1892.
- Il MUP fu fondato a Milano il 10-1-1943. Vi aderivano alcuni futuri dirigenti socialisti di spicco come Carlo Andreoni, Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Domenico Viotto.
- Ne facevano parte, fra gli altri, Giuliano Vassalli, Vezio Crisafulli, Mario Zagari, Tullio Vecchietti, Leo Solari.
- Per il PSI/IOS erano presenti anche Pietro Nenni, Bruno Buozzi e Sandro Pertini, tutti e tre reduci dal confino. Il 25-7-1943 era infatti caduto il governo fascista di Mussolini, che era stato sostituito dal governo monarchico del maresciallo Pietro Badoglio, e i confinati erano stati gradualmente liberati.
- Le vicende relative alla ricostituzione del partito socialista sono raccontate, con la passione del politico e con la precisione dello storico, nel libro di Oreste Lizzadri Il Regno di Badoglio.
- Della Direzione facevano parte Pietro Nenni (segretario), Sandro Pertini (vicesegretario), Giuseppe Saragat, Rodolfo Morandi, Bruno Buozzi, Emilio Canevari, Giuseppe Romita, Oreste Lizzadri, Nicola Perrotta. Marcello Cirenei, Vannuccio Taralli, Filippo Acciarini, Carmine Mancinelli (ex PSI); Lelio Basso, Carlo Andreoni (vicesegretario), Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Roberto Verari, Gianguido Borghese (ex MUP); Giuliano Vassalli, Mario Zagari, Vezio Crisafulli, Tullio Vecchietti (ex UP).
- Il Re e il suo governo si stabilirono prima a Brindisi e poi a Salerno.
- Ne facevano parte sei partiti: PCI, PSIUP, PdAz, Democrazia del Lavoro, DC, PLI. Il PSIUP vi era rappresentato da Pietro Nenni e Giuseppe Romita. Il 17-10-1943 fu stipulato un nuovo Patto di unità d'azione fra PCI e PSIUP, per il quale firmarono Pietro Nenni, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat.
- Giuliano Vassalli (1915-2009) , partigiano socialista, durante la Resistenza riuscì a liberare dal carcere di Regina Coeli (24-1-1944), Sandro Pertini e Giuseppe Saragat. Arrestato poi dai nazisti a sua volta, sarà torturato dalle SS.. Diventerà Presidente della Corte Costituzionale.
- Lelio Porzio (1895-1981), avvocato, aderì al PSI nel 1920. Fu attivissimo dirigente socialista nel Meridione d'Italia durante la guerra. Dal 1946 al 1968 fu consigliere comunale di Napoli ed anche vicesindaco.
- Tale posizione in un certo senso anticipava la cosiddetta “svolta di Salerno”, poco dopo espressa dal leader comunista Palmiro Togliatti, al suo rientro in Italia dall'Unione Sovietica, dove era stato in esilio.
- Della Direzione “meridionale” facevano parte: Lelio Porzio (segretario), Giovanni Ardengo, Luigi Cacciatore, Nino Gaeta, Giuseppe Laricchiuta, Pietro Mancini, Luigi Numis, Renato Sansone, Vincenzo Vacirca.
- Il 22-4-1944 il PSIUP entrò nel 2° governo Badoglio con due ministri: Pietro Mancini (ministro senza portafoglio) e Attilio Di Napoli (Commercio, Industria e Lavoro) e con due sottosegretari: Nicola Salerno (Interno) e Domenico Albergo (Marina).
- Egli stesso fu nominato vicecommissario della Confederazione dei lavoratori agricoli, con Commissario il sindacalista cattolico Achille Grandi. Nello stesso tempo il socialista Bruno Buozzi fu nominato alla guida dei lavoratori dell'industria e al comunista Giuseppe Di Vittorio fu assegnata la guida dei braccianti agricoli, scorporati dai lavoratori agricoli.
- Bruno Buozzi (1881-1944), operaio metallurgico, nel 1905 aderì al PSI e poi alla FIOM, di cui nel 1911 divenne segretario generale. Deputato socialista dal 1919 al 1926, nel dicembre 1925 divenne segretario generale della CGdL. Ma nel 1926 il pericolo fascista lo costrinse a riparare in esilio a Parigi, dove ospitò Filippo Turati, anch'egli in esilio. Ritornato in Italia, aderì alla Resistenza. Catturato dai nazisti, fu da loro assassinato, assieme ad altri militanti socialisti e antifascisti.
- Il 15 maggio 1943, in seguito allo scioglimento dell'Internazionale Comunista, il nome del partito comunista fu cambiato da Partito Comunista d'Ítalia (PCdI) in Partito Comunista Italiano (PCI).
- La nuova Direzione comprendeva i massimi esponenti del socialismo italiano: Lelio Basso, Luigi Cacciatore, Giuseppe Faravelli, Alberto Jacometti, Oreste Lizzadri, Foscolo Lombardi, Virgilio Luisetti, Carmine Mancinelli, Lina Merlin, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni (segretario generale), Sandro Pertini (segretario), Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Olindo Vernocchi. Con voto consultivo il direttore dell'Avanti! Guido Mazzali.
- La Consulta Nazionale era un'assemblea legislativa provvisoria, non elettiva, da durare fin quando non fosse stato possibile indire regolari elezioni. Essa ebbe vita dal 25-9-1945 al 1° giugno 1946. Il PSIUP vi ebbe 38 seggi (capogruppo Giuseppe Romita) su un totale di 430, attribuiti secondo quanto stabilito da un precedente decreto legislativo. Presidente ne fu Carlo Sforza (PRI).
- Nella nuova Direzione vennero eletti: Lelio Basso, Luigi Cacciatore, Luigi Chignoli, Alberto Jacometti, Foscolo Lombardi, Ivan Matteo Lombardo, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Alberto Simonini, Aldo Valcarenghi, Mario Zagari, Lina Merlin (per le donne), Matteo Matteotti (per i giovani) Oreste Lizzadri (per i sindacalisti).
- Il partito fondato da Saragat e dalla maggioranza delle correnti socialiste di „Critica Sociale“ e di „Iniziativa Socialista“ prese il nome di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) e successivamente di Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI). Nello stesso tempo il PSIUP riprese il nome classico di PSI.
- La CGIL aveva subito due scissioni nel 1948: la prima componente a lasciare la CGIL fu quella cattolica, che nell'ottobre 1948 costituì la Libera CGIL, guidata da Giulio Pastore; nel giugno 1949, uscirono le componenti socialdemocratica e repubblicana che dettero vita alla Federazione Italiana dei Lavoratori (FIL), che il 5-3-1950 divenne Unione Italiana del Lavoro (UIL), con segretario Italo Viglianesi; il 1°-5- 1950 il sindacato influenzato dalla DC si riorganizzò come Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), con segretario Giulio Pastore. Rimasero, invece nella CGIL le correnti comunista e socialista, con segretario Giuseppe Di Vittorio.
- Riccardo Fabbri (1920-1967) proveniva dal Partito d'Azione, confluito nel PSI nel 1947. Partecipò alla Resistenza nelle formazioni di “Giustizia e Libertà”. Catturato dai fascisti repubblichini fu torturato tanto da rimanere invalido. Sindacalista, segretario nazionale dei Postelegrafonici della CGIL dal 1958, fu eletto deputato nel 1958 e nel 1963.
- Il primo governo di centro- sinistra “organico”, presieduto da Aldo Moro e sostenuto da DC, PSI, PSDI, PRI durò dal 4-12-1963 al 22-7-1964. Nenni, divenuto vicepresidente del Consiglio, lasciò la carica di segretario del PSI, che fu affidata a Francesco De Martino, con suo vice Giacomo Brodolini.
- Il PSIUP (da non confondere col PSIUP del 1943, da cui aveva preso solo il nome) fu fondato il 12-1-1964, con segretario Tullio Vecchietti e presidente Lelio Basso. Si scioglierà il 13-7-1972. Organo del PSIUP era il settimanale Mondo Nuovo, con direttore Lucio Libertini.
- In giornale l'Unità del 20-6-1954.
- Il riferimento è non solo al fatto che il congresso del PSI (Roma, 10-14/11/1965) aveva riconosciuto la formula di centro-sinistra come salvaguardia della democrazia italiana, ma che aveva anche auspicato la riunificazione col PSDI e il rientro nell'Internazionale Socialista, obiettivi che Lizzadri considerava uno spostamento a destra del PSI.
- In Mondo Nuovo n. 51 del 26/12/1965.
- Ib.
- La Direzione del PSIUP risultò così composta: Lelio Basso (presidente del Comitato Centrale), Tullio Vecchietti (segretario), Dario Valori (vicesegretario), Lucio Libertini (direttore di Mondo Nuovo), Vincenzo Ansanelli, Domenico Ceravolo, Salvatore Corallo, Andrea Filippa, Vincenzo Gatto, Elio Giovannini, Francesco Lami, Mario Livigni, Oreste Lizzadri, Luigi Locoratolo, Lucio Luzzatto, Alessandro Menchinelli, Giuseppe Pupillo, Carlo Sanna, Fernando Schiavetti.
- Sulla nascita del PSI-PSDI Unificati e sulla sua scissione si possono vedere i due saggi, entrambi di Ferdinando Leonzio, pubblicati su La Rivoluzione Democratica, rivista mensile online: L'unificazione socialista del 1966-69 (giugno 2019) e Il Partito Socialista Unitario 1969-1971 3° (luglio 2019).
- Nello stesso anno pubblicò un'opera di grande interesse storico: Il socialismo italiano dal frontismo al centro sinistra.
Fonte: di Ferdinando Leonzio











